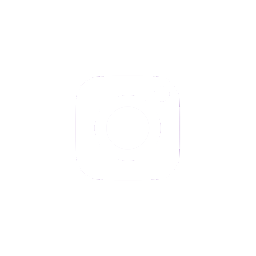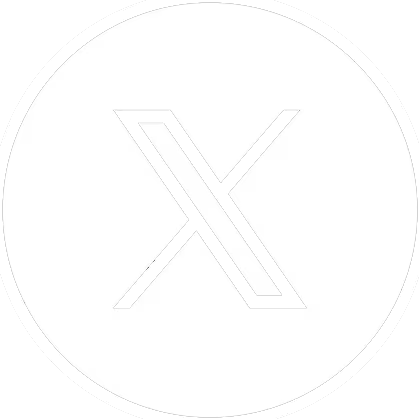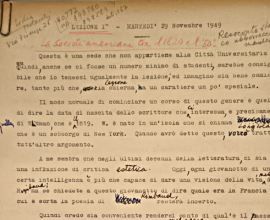Emergenza COVID-19 nelle carceri USA
Domenica 24 maggio la prima pagina del “New York Times” ha ospitato i nomi di 1.000 dei quasi 100.000 deceduti a causa del COVID-19 negli Stati Uniti, una prima pagina destinata ad entrare nella storia e nella memoria della fase drammatica che stiamo vivendo.
Secondo quanto riportato alcuni giorni fa dal quotidiano, tre dei maggiori cluster della diffusione della malattia nel Paese sono all’interno di istituti penitenziari. I dati disponibili sull’impatto dell’epidemia nei centri di detenzione (inclusi quelli destinati agli immigrati, che meritano un discorso a sé) sono incompleti e probabilmente continueranno ad esserlo a lungo: la quantità di test somministrati varia, e di molto, a seconda dei casi e c’è una certa reticenza alla condivisione dei risultati da parte di chi gestisce le strutture. I numeri che abbiamo, comunque, fanno impressione. Mentre alcuni progetti ad hoc come il Covid-19 Behind Bars Data Project del Dipartimento di legge della University of California, Los Angeles (UCLA) e il Marshall Project continuano ad effettuare un costante lavoro di monitoraggio, la stampa ha iniziato a mettere insieme e analizzare i dati più completi. Reuters, ad esempio, ha presentato uno studio su 37 prigioni statali che hanno effettuato test a tappeto rivelando la presenza di 10.000 casi confermati su 44.000 testati e 91 morti in nove stati. Le prigioni federali, che effettuano i test solo gli individui sintomatici, hanno riportato 4.200 casi confermati su una popolazione totale di circa 150.000 persone, oltre a 52 morti. Non si sa nulla, invece, dell’incidenza della malattia nelle 4.800 prigioni locali. A questi numeri vanno aggiunti quelli delle carceri minorili, dove la diffusione del nuovo coronavirus è altrettanto preoccupante. Gli screening suggeriscono, in ogni caso, che il nuovo coronavirus circoli in modo molto massiccio nelle prigioni, luoghi idealmente chiusi, isolati dal resto del mondo e quindi protetti ma nei quali basta un infetto per avere una reazione a catena.
Gli Stati Uniti hanno la più numerosa popolazione carceraria del mondo. A fine 2018, secondo gli ultimi dati disponibili del Bureau of Justice Statistics, l’agenzia governativa che pubblica le statistiche relative ai crimini commessi nel Paese, i detenuti nelle prigioni federali, statali e locali, tra condannati e persone in attesa di giudizio, ammontavano a circa 2.2 milioni di persone. Un numero che ha subito un’impennata a partire dagli anni Ottanta, in corrispondenza della “war on drugs” che diede avvio al fenomeno della cosiddetta “mass incarceration”, frutto di scelte politiche e di una cultura sempre più incline alla punizione piuttosto che alla riabilitazione. Si è giunti, così, alla reclusione di tantissime persone per reati minori, soprattutto quelli legati al possesso di sostanze stupefacenti, anche se droghe leggere e in piccole quantità. I dati sui detenuti parlano molto chiaro e rivelano quanto la questione si intrecci con la sistematica discriminazione razziale e con la povertà dilagante in alcune zone degli Stati Uniti. Solo negli ultimissimi anni si sta assistendo ad una flessione dei numeri, dovuta anche al dibattito fitto che si è sviluppato intorno al tema e che coinvolge associazioni per i diritti civili, movimenti sociali, intellettuali e politici.
Quando l’epidemia di COVID-19 è arrivata negli Stati Uniti, o meglio quando si è cominciato a capire che fosse arrivata, le grida d’allarme sullo stato delle prigioni e la possibilità che diventassero luoghi di contagio esplosivo sono state immediate. Come si può garantire la sicurezza sanitaria in strutture che spesso sono sovrappopolate e nelle quali le persone condividono celle, mense, spazi comuni, in condizioni igieniche inadeguate, dove si fa fatica ad avere sapone e dove non si può, per legge, mettere a disposizione sostanze idroalcoliche (i detergenti per le mani che non hanno bisogno di risciacquo) per il rischio di ingestione da parte dei detenuti?
Dopo che Donald Trump ha dichiarato lo stato d’emergenza nazionale, il Bureau of Prisons (BOP), il ramo del Dipartimento di Giustizia deputato alla cura delle strutture detentive federali, ha adottato delle prime linee guida che prevedevano regole per il distanziamento sociale, limitazione degli spostamenti dei detenuti, sospensione o riduzione delle visite dall’esterno. Misure che sono state adottate anche nelle carceri minorili, che ospitano circa 48.000 persone e dove sono stati sospesi i programmi scolastici e le altre attività educative, riportando indietro di vent’anni gli sforzi per dare ai minori reclusi la possibilità di ricevere una formazione utile in vista del reinserimento.
Successivamente, è stato ordinato il lockdown di 14 giorni e misure per la quarantena dei malati, che spesso si traducono in un isolamento peggiore della “normalità” carceraria. A fine marzo, con l’approvazione del cosiddetto CARES Act, il pacchetto di aiuti economici appuntato per fronteggiare l’emergenza, il Congresso ha dato mandato al Dipartimento di Giustizia di allargare i criteri per la concessione di misure di detenzione alternative al carcere o la riduzione della pena. Alcuni giorni dopo, il Procuratore generale William Barr ha fatto circolare un memorandum in cui richiedeva ai responsabili delle prigioni federali di intensificare gli sforzi per rilasciare i prigionieri vulnerabili, escludendo chi avesse commesso crimini violenti o fosse a rischio di recidiva ma senza dare ulteriori indicazioni su chi fosse da considerare idoneo. Dopo qualche settimana di confusione nella quale diversi detenuti hanno ricevuto indicazioni contrastanti, il 24 aprile il BOP ha fornito alcuni chiarimenti. Tra i candidati per il rilascio preventivo rientrava, sempre facendo salvi i criminali violenti o considerati pericolosi per la comunità, chi avesse già scontato almeno metà della pena (un criterio che non è stato rispettato almeno in un caso, quello dell’ex avvocato e fedelissimo di Trump, Michael Cohen, condannato a tre anni per vari capi di imputazione tra cui evasione fiscale e violazione delle regole di finanziamento elettorale nel 2018, che è uscito dal carcere in anticipo il 21 maggio scorso).
Le persone recluse nelle prigioni federali sono comunque una minoranza. La maggior parte, circa 1.3 milioni, è detenuta nelle strutture statali. In queste ultime e nelle carceri locali, il numero dei prigionieri a cui è stata commutata la pena a causa dell’epidemia varia. Secondo un recente report del Vera Institute for Justice, nelle ultime settimane la popolazione in attesa di giudizio si è ridotta quasi ovunque di almeno un quarto. Per quanto riguarda chi sta scontando la pena, invece, la situazione è molto diversa. A conti fatti, la popolazione di questi ultimi si è ridotta solamente dell’1.6% nel primo trimestre del 2020, a dimostrazione delle lungaggini che ci sono dietro all’applicazione di un principio di buon senso per la salute pubblica come quello della commutazione delle pene carcerarie.
Intanto, il Solicitor General Noel Francisco, che agisce in rappresentanza dell’amministrazione, si è rivolto alla Corte Suprema per bloccare l’ordine di un giudice dell’Ohio per gli arresti domiciliari o il rilascio di anziani o malati mentre l’American Civil Liberties Union (ACLU) ha presentato diverse class action contro i dirigenti delle prigioni nelle quali i detenuti sostengono che le misure per il contenimento dell’epidemia non vengono rispettate.
La questione è destinata a diventare materia legale, oltre che sociale. Come è successo in Italia, le misure per il contenimento del virus hanno portato a diverse proteste da parte dei detenuti e dei familiari in varie zone del Paese, ad esempio a Philadelphia e a Columbus, in Ohio. Tutto ciò, insieme alla crescente attenzione che le riservano i media, potrebbe aumentare la coscienza collettiva su un fenomeno di cui si discute da anni e che, pur restando divisivo, viste le circostanze straordinarie potrebbe far riconsiderare lo stato della giustizia e del sistema carcerario negli Stati Uniti. Il dibattito politico potrebbe sfociare in una qualche forma di novità, sempre che si trovino interlocutori capaci e volenterosi di raccogliere le istanze della cittadinanza attiva.
Alice Ciulla – Università di Roma Tre