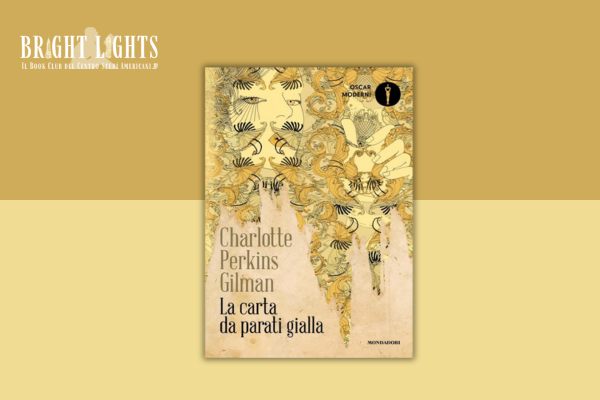Charlotte Perkins Gilman – La carta da parati gialla
È il 1887 e Charlotte Perkins Gilman ha appena dato alla luce la sua prima figlia, Katharine. Già incline alla depressione, la salute della giovane scrittrice peggiora ulteriormente, oppressa dal matrimonio e dalla nuovissima esperienza di maternità. Il dottor Mitchell, l’esperto più prominente di salute femminile all’epoca le consiglia il riposo completo, anche dalla scrittura. Per Gilman è la fine. La depressione peggiora finché non decide di tornare a fare forse l’unica cosa che, a sua detta, le riuscirà meglio nella vita: scrivere. Da quel ritrovato tentativo nascerà “La carta da parati gialla”, uno dei racconti gotici e femministi più famosi di sempre.
Con la lettura di dicembre, il Bright Lights Bookclub si immerge tra le pagine di Charlotte Perkins Gilman. Autrice acclamata a livello mondiale almeno fino alla Prima Guerra Mondiale, Gilman rimane un punto di riferimento per le scrittrici a lei successive almeno per quello che riguardava le tematiche gotiche, presenti nel racconto citato in precedenza. Riscoperta, poi, intorno agli Settanta come autrice femminista da Elaine Hedges, Gilman si assicura un posto d’onore tra le scrittrici più influenti a cavallo tra Ottocento e Novecento.
Si può dire che i racconti de La carta da parati gialla (Mondadori 2023) raccolgono tutti gli elementi che hanno reso l’autrice rinomata nel panorama letterario novecentesco. Con Gilman, infatti, il gotico si mescola a un sottotesto nemmeno troppo nascosto di stampo protofemminista, ovvero che intuisce e sviluppa le grosse tematiche del femminismo degli anni Settanta del Novecento. Quasi ottant’anni prima, Gilman riesce a intessere discorsi sovversivi sul matrimonio, la maternità e il ruolo sociale della donna solo attraverso la sua penna. Nonostante i numerosi saggi scritti, Charlotte Perkins Gilman si afferma forse di più come scrittrice gotico-femminista proprio grazie ai suoi racconti, molti dei quali contenuti in quest’opera.
I due racconti più famosi sono senza dubbio “La carta da parati gialla” e “Il glicine gigante”. Si tratta di due testi dove un elemento esterno troneggia e si insidia nella mente dei protagonisti e di chi legge. Da una parte la carta da parati gialla – per la critica di genere un elemento dai richiami sociali che riguardano il patriarcato e un colore, il giallo, che già all’epoca di Gilman simboleggiava la vita domestica ma anche la modernità, la decadenza di fine secolo e i movimenti femministi – dall’altra il glicine. Entrambi si rendono soggetti immoti e in apparenza innocui delle storie, tuttavia occupano allo stesso tempo uno spazio sia fisico che metaforico maggiore rispetto a quello che naturalmente gli spetterebbe.
Infatti, la carta da parati gialla è appiccicata al muro della stanza dove la protagonista è costretta a passare buona parte del suo tempo e finisce per dominare la scena. Il glicine si avviluppa intorno alla casa e fino alle fondamenta. La risoluzione di entrambi i racconti, assai trasparenti nei loro intenti sociali, è lo sradicamento – letterale e metaforico – dell’elemento dominante. Tuttavia, non si tratta di qualcosa di negativo, anzi: se da una parte la rimozione forzata della carta da parati è parallela alla liberazione della protagonista, la rimozione del glicine dal porticato che ha ormai occupato svela al mondo i segreti orribili di quella casa, dando pace a una donna e madre che aveva sicuramente sofferto l’oppressione sociale della sua sfortunata condizione.
È proprio lo sradicamento, tema comune non solo ai due racconti più famosi ma anche in parte degli altri della raccolta, a creare lo sconcerto del quotidiano e, di conseguenza, l’effetto gotico percepito da chi legge. Gilman riesce a sviluppare una narrazione gotica basata su ciò che è maggiormente conosciuto senza servirsi del sovrannaturale ma, al contrario, degli stereotipi che alla fine ribalta e sradica completamente. È ciò che succede con il racconto “La madre snaturata”, in cui l’autrice mette in dubbio l’idea di istinto materno e di cura in una comunità – di donne, in questo caso – che percepisce il primo come imprescindibile e prevalente sul senso di comunità. Con questo racconto nello specifico, Gilman si rivela un’autrice profondamente interessata ai discorsi di economia sociale: una delle domande che il racconto pone a chi legge riguarda, infatti, l’idea che l’accudimento dei figli sia una questione esclusivamente privata e non un dovere della comunità.
Come sottolinea Stella Sacchini nell’introduzione alla raccolta, questi racconti hanno tutti un fine comune che si realizza o in maniera distruttiva – e non a caso quelli dalla linea più gotica rientrano in questa categoria – o costruttiva – come nel caso di “Voltare pagina” e “Cambiamenti”, due racconti solido sulla solidarietà femminile -. I paradigmi del matrimonio, delle relazioni di genere e della maternità che dominano tutti i racconti di Gilman non vengono del tutto distrutti bensì sradicati dal terreno marcio sul quale poggiano da secoli e sovvertiti nella loro percezione sociale.
Francesca Titolo – Le ore dentro ai libri
UNISCITI AL BRIGHT LIGHTS BOOKCLUB