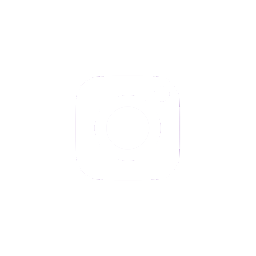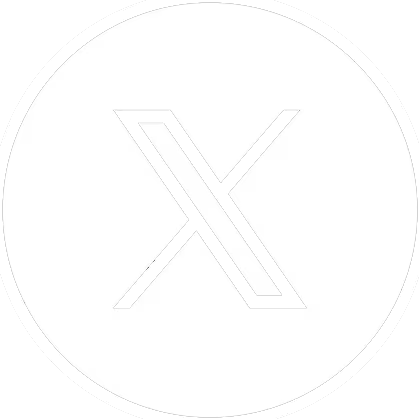Il Prof. John Harper sullo stato delle democrazie
L’intervento del Professor John Harper sullo stato delle democrazie – 10 marzo 2022
Come storico della politica estera americana la domanda che mi pongo è: quale politica estera è la più idonea alle circostanze? Quale politica estera è più in grado di rafforzare la democrazia americana sotto stress?
In questo momento non si può non rispondere la politica estera che Donald Trump ha deriso e che avrebbe voluto cestinare—la politica di solidarietà con i nostri partner democratici europei, una politica estera che fa il possibile per contrastare il tentativo di schiacciare la democrazia in Ucraina.
Allo stesso tempo nel dopo-Trump non prevedo un ritorno in grande stile alla politica estera americana predominante dalla fine della seconda guerra mondiale in poi, ossia dell’internazionalismo liberale.
Intendo una politica estera — un programma di ordine mondiale— con due aspetti essenziali: il primo è la globalizzazione economica, ossia la rimozione progressiva e deliberata delle barriere alla libera circolazione di beni, del capitale e delle persone.
Il secondo aspetto è la leadership politica e militare americana. Gli SU come indispensabile potenza egemone nelle zone chiavi del mondo, gli SU come protettori e esportatori della democrazia.
Una politica estera basata implicitamente sul messianismo americano. L’America come campione di un modello destinato a trionfare dovunque e per citare George W. Bush, “che ha come obbiettivo ultimo l’eliminazione della tirannia sulla terra.”
Dati i risultati di questa politica estera negli ultimi decenni, data la probabilmente irreversibile diffusione del potere nel mondo—è chiaro che questa politica estera appartiene al passato e c’è bisogno di elaborare una politica estera diversa. Non una politica isolazionista la quale non avrebbe senso—né una versione riscaldata di America First—la quale ha dimostrato tutti i suoi limiti—ma nella mia modesta opinione una politica estera più trattenuta e più selettiva nei suoi obbiettivi.
La penso così per diversi motivi ma soprattutto perché una politica estera più trattenuta e selettiva è quella più salubre per la democrazia americana.
E’ utile ricordarsi che alcuni dei fondatori della democrazia americana— Jefferson, Madison, e John Adams– in particolare si opponevano ad una politica di potenza per gli SU perché avrebbe fatto crescere il potere dell’esecutivo e dell’arma militare dello stato in un modo malsano e avrebbe sovvertito la democrazia.
Oggi possiamo vedere che l’iper-attivismo della politica estera americana dal 2001 in poi è andato di pari passo con innumerevoli abusi di potere dell’esecutivo nel campo dell’uso della forza, e con un indebolirsi del sistema di pesi e contro pesi. Si stima che gli interventi americani in Iraq e Afghanistan siano costati almeno 8 trilioni di dollari, e una politica estera meno militarizzata permetterebbe agli SU di riallocare risorse per lo sviluppo di un più forte stato sociale di cui c’è urgente bisogno. Ma vorrei soffermarmi su un’altra considerazione.
Torniamo all’ascesa di Donald Trump nel 2016—ricordiamoci peraltro che Trump ha preso più voti –molti di più– nel 2020 che nel 2016. L’ascesa di Trump si spiega guardando l’interazione di tendenze del lungo periodo e fattori contingenti. Il fattore contingente più importante fu probabilmente la scelta di Hilary Clinton come candidato democratico, purtroppo un bersaglio fatto su misura per l’astio dei sostenitori di Trump. Ma ci furono fattori più profondi all’opera— e uno di questi fu una specie di rivolta popolare contro una politica estera basata sulla globalizzazione economica e l’interventismo militare.
L’aspetto più polarizzante della globalizzazione è stato una politica di immigrazione aperta dagli anni ‘60 in poi. Nel 2016, si stima che ci fossero 11 milioni di immigrati illegali residenti negli USA. Tra il 2000 e il 2010, peraltro, gli SU hanno perso quasi 6 milioni di posti di lavoro nel settore manifatturiero – un calo del 34%. Una delle ragioni è stata la competizione della Cina e di altri paesi con manodopera a basso costo, che ha spinto le aziende americane verso l’automazione e la delocalizzazione della produzione. I tassi di occupazione migliorano sotto Obama, ma nel 2016 nelle zone rurali erano ancora ben al di sotto di quelli precedenti alla grande recessione. Moltissime delle contee che votarono per Trump— nel mio stato di Pennsylvania per esempio– hanno vissuto forte perdite di posti di lavoro dal 2000 in poi. Penso inoltre che la distinzione netta che si fa spesso tra fattori economici e fattori culturali nell’ascesa di Trump sia fuorviante. Il malessere economico predispone le persone verso la ricerca di capri espiatori e verso un maggior tribalismo etnico e razziale.
Già nel 2012 Francis Fukuyama scrisse, “la forma attuale di capitalismo globalizzata sta intaccando la base sociale borghese sulla quale poggia la democrazia liberale.” Nel 2016, scrisse:
La vera storia de queste elezioni è che dopo alcuni decenni la democrazia americana sta finalmente rispondendo alla crescente disuguaglianza e alla stagnazione economica vissuta da una parte consistente della popolazione… Data l’enormità del cambiamento sociale… la vera questione non è perché c’è il populismo nel 2016 ma perché l’esplosione non era avvenuta molto prima.
Avrebbe potuto aggiungere che quella parte della popolazione non sentiva più rappresentata dalla sinistra americana—cioè dal partito democratico.
Donald Trump ha battuto non solo sul tasto della globalizzazione ma quello che ha chiamato “Queste ridicole guerre senza fine.” Nel ’16 c’erano circa 22 milioni di veterani militari. Ovviamente non tutti votarono, ma il 60 percento di quelli che votarono, votarono per Trump, non perché prometteva nuove avventure militari ma perché condannò le guerre senza fine. Nel 2020 una netta maggioranza dei veterani ha votato ancora per Trump.
Ma qual è il punto? Il punto è semplicemente che una politica estera basata sulla globalizzazione sfrenata e l’interventismo spericolato ha minato la democrazia americana nutrendo il bacino elettorale di un demagogo sciovinista—e un abilissimo imprenditore politico– come Trump. Ovviamente non è una spiegazione esaustiva né della crisi della democrazia americana né dell’ascesa di Donald Trump ma è un fattore che va preso seriamente in considerazione.
Non ho tempo di elaborare in dettaglio la politica estera che le circostanze richiedono ma direi che sia una che rinuncia al tentativo di esportare la democrazia con la forza,
che rifiuta la premessa che la leadership americana sia automaticamente indispensabile per la sicurezza di ogni angolo del mondo e pertanto incoraggia una maggior autonomia strategica europea, ed è una politica che pone dei chiari limiti alla globalizzazione economica. Per citare un commentatore saggio Walter Lippmann, è una politica estera solvibile, che mira ad un equilibrio tra gli impegni della nazione e le sue limitate risorse. Infine è una politica che si ispira alle parole di un diplomatico saggio, George Kennan, che disse:
“È principalmente grazie al il suo esempio che un paese come il nostro esercita la più utile influenza al di là delle sue frontiere . . . e se non preserviamo la qualità, il vigore, e il morale della nostra società, non saremo di grande utilità a nessuno.”